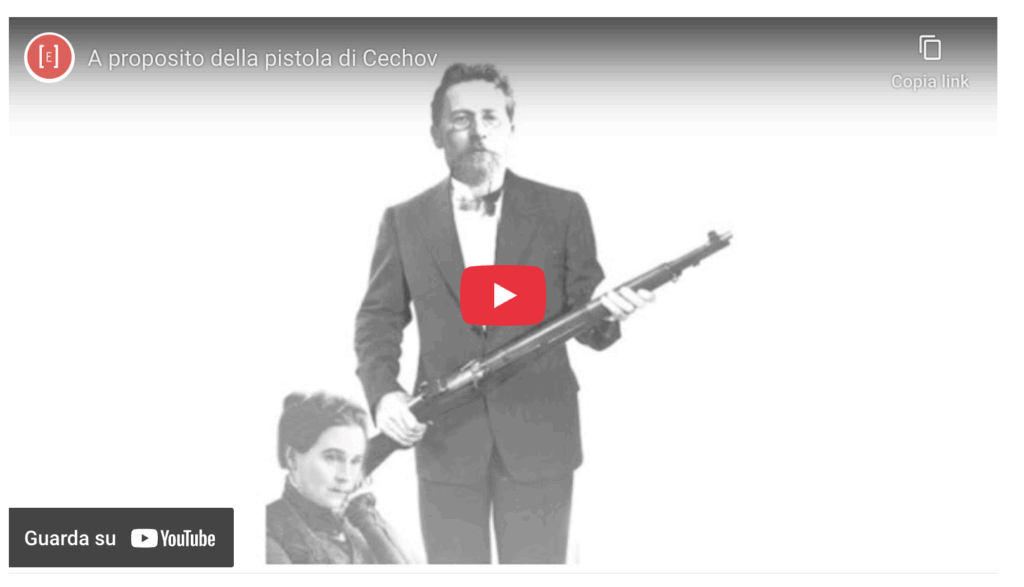
A proposito della pistola di Čechov
Articolo a cura di Marco Mastrorilli, tratto da LibriCK – La rivista degli scrittori n. 4.
Quando si parla di scrittura esistono diverse teorie, principi e insegnamenti che possono rendere più performante il nostro percorso di storytelling.
Se pensiamo allo Show don’t tell, insegnato e raccomandato ad ogni novello aspirante scrittore, e alla teoria dell’iceberg che ha influenzato l’opera di Hemingway, ci rendiamo conto dell’importanza di tali canoni letterari nella stesura delle opere.
Nel corso dei decenni diversi scrittori famosi, più o meno involontariamente, ci hanno fornito teorie e consigli per migliorare la scrittura, dedicati ad autori, giornalisti o “scrittori per diletto”.
Tra queste teorie di scrittura ritroviamo una tecnica suggerita nel secolo scorso dallo scrittore e drammaturgo russo Anton Pavlovič Čechov, grande protagonista della letteratura del XIX secolo.
Quello della pistola di Čechov è un principio drammaturgico importante nella narrazione romanzesca, teatrale ed anche visual-cinematografica.
Si tratta di un principio applicato molto spesso e conoscerlo meglio può aiutarci a comprendere il tessuto narrativo di una storia, sia nell’ambito di un romanzo, sia in sceneggiature cinematografiche.

La pistola di Čechov è una tecnica letteraria in cui un oggetto, qualsiasi esso sia, in un certo momento della storia assume un ruolo rilevante nella narrazione. Sovente presentato con poca evidenza, riemerge come elemento risolutore nella narrazione qualche capitolo più avanti, spesso nell’epilogo.
La tecnica è stata espressa da Anton Čechov, che ha spiegato come una pistola appesa a un muro nel primo capitolo di romanzo o in un primo atto di un dramma, debba essere impiegata, ovvero “sparare” in una sequenza narrativa successiva.
Il concetto espresso dal romanziere russo evidenzia che se la pistola non viene utilizzata può costituire una semplice distrazione, a meno che non sia stata inserita, magari in un contesto da giallo o noir, per creare un falso indizio.
È importante evidenziare che la pistola di Čechov non allude specificamente alle armi, infatti questa tecnica si riferisce ad un qualsiasi dettaglio all’interno di una narrazione.
Oggetti quindi rilevanti per lo sviluppo della storia.
Questo strumento è utile non solo in libri di genere noir o gialli, ma in qualsiasi soggetto, perché potrebbe divenire davvero elemento determinate per le vicende di un personaggio o dell’intera storia.
Uno degli esempi più interessanti lo troviamo nel bestseller Il Codice da Vinci dove nella parte iniziale del romanzo, il protagonista Langdon interpretato da Tom Hanks nella trasposizione cinematografica, raggiunge il Museo del Louvre e si trova di fronte alla piramide di vetro.
«[…] La Pyramide. Il nuovo ingresso del Louvre parigino era divenuto famoso quanto il museo stesso».
Per tutto il romanzo questo dettaglio narrato quasi fosse una semplice appendice descrittiva ambientale, diventa il fulcro del libro proprio nella penultima pagina, in quello che Brown intitola come epilogo, in piena fedeltà al principio di Čechov.
Infatti, Dan Brown rispolverando in pieno la teoria dello scrittore russo, usa la sua pistola, quando il protagonista Langdon ha l’intuizione e soluzione dell’enigma del Graal proprio guardando la Piramide.
«[…] nel centro, tuffata nella terra come un abisso di cristallo, c’era la grande piramide di vetro da lui vista alcune notti prima, quando era passato per l’ingresso sotterraneo del Louvre. La Pyramide inversée. Tremante Langdon si spinse fin sull’orlo e osservò il sotterraneo, illuminato da un luce color ambra. […] Oltrepassò la porta, scese la scalinata e si allontanò lungo l’atrio sotterrane, in direzione della Pyramide inversée. Andò avanti di corsa finché non arrivò in una vasta sala, Sopra di lui, sospesa al soffitto, luccicava la piramide inversa. Un enorme sagoma di vetro a forma di V, così grande da togliere il fiato. “Il calice”».
In questo finale mozzafiato proposto dallo scrittore americano, emerge il concetto di foreshadowing ovvero della prefigurazione, correlato alla pistola di Čechov. La prefigurazione è il momento nel quale lo scrittore lascia piccoli indizi sugli eventi futuri nella narrazione, che sono compresi più chiaramente dopo che l’evento è noto.
La pistola di Čechov riguarda più la rimozione di informazioni e descrizioni estranee che la stratificazione di indizi per il lettore.
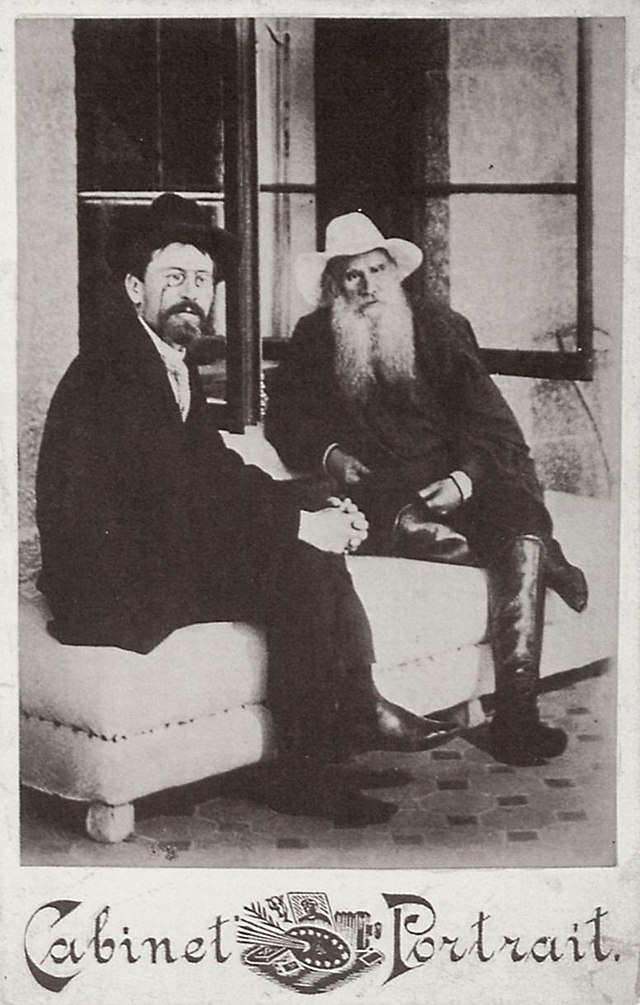
Se una pistola carica è descritta nel primo atto e non ha mai sparato, non è affatto necessario descrivere la pistola, perché è irrilevante.
Questo principio è molto utile nello storytelling, sia testuale che visuale, perché ci suggerisce di non inserire mai elementi e dettagli che potremmo definire superflui, ma anzi posizionare nelle pagine o nelle sequenze filmiche aspetti che diverranno rilevanti per concludere la narrazione.
Ogni teoria trova sostenitori, ma anche qualche osservazione critica. La tecnica di Čechov venne infatti criticata da Murakami nel suo libro 1Q84.
Haruki Murakami in 1Q84 pone un accento critico che ispira qualche riflessione, imputando allo scrittore russo lo stigma dell’artificio:
« Ĉechov è un grande scrittore, ma il suo modo di pensare non vale per tutti. Non è vero che tutte le pistole che appaiono in una storia debbano fare fuoco. […] Non è vero che tutte le pistole debbano fare fuoco, – si disse Aomame mentre era sotto la doccia. Una pistola non è altro che uno strumento. E quello in cui vivo non è un mondo di finzione. È un mondo reale, pieno di smagliature, difformità, anticlimax».
Murakami è un autore molto attento alle tecniche di scrittura, in un suo interessante saggio pubblicato da Einaudi, Il mestiere dello scrittore, sottolinea alcune regole che si è posto lui stesso, posizionando al primo posto la formazione di un proprio stile, con una ricerca di originalità.
Egli, che ammira molto Hemingway, evidenzia in questo libro quanto sia influenzato dalla teoria dell’iceberg ponendo l’accento sull’importanza di scrivere frasi brevi.
Per contro, Murakami afferma che per formare un proprio stile è bene seguire alcune regole, per poi trasgredirle seguendo il proprio istinto.
Lo scrittore statunitense Chuck Palahniuk, famoso per il best seller Fight Club, dibatte a sua volta il pensiero di Murakami; per lui la pistola di Čechov è: «una promessa o una minaccia che va mantenuta per concludere una storia».
In concreto è uno strumento del quale il narratore si serve per avere la chiave per portare all’epilogo una storia senza che diventi lunga e stucchevole, perdendo quell’energia espressiva che rende grandi alcune opere.
La pistola di Čechov può essere adottata in qualsiasi narrazione ma è indubbio che risulti efficace in alcuni generi come il giallo, il noir, il fantasy, il romanzo storico.
In questi ultimi anni le sceneggiature delle serie TV, o gli scrittori di saghe che cavalcano generi di grande successo nel panorama della scrittura letteraria e filmica, usano in modo ripetuto la pistola di Čechov.
Pensiamo ai molti dettagli profusi nella narrazione che poi vengono ripresi a volte anche a distanza di puntate o di libri precedenti per creare i collegamenti con le opere passate.
Che lo scrittore russo Čechov fosse realmente convinto di questo principio emerge anche in alcune lettere di oltre un secolo fa.
« Rimuovete tutto ciò che non ha attinenza con la storia. Se nel primo capitolo dite che c’è un fucile appeso al muro, nel secondo o nel terzo capitolo deve assolutamente esplodere. Se non si spara, non dovrebbe essere appeso lì».
Lo stesso Čechov rincara questa dose in una lettera ad Aleksandr Semenovich Lazarev (pseudonimo di Gruzinsky). Era il 1 novembre 1889: «Non si deve mai mettere un fucile carico sul palco se non sta per esplodere. È sbagliato fare promesse che non si intende mantenere».
L’uso di questa tecnica è ormai davvero frequente, ma è il suo uso magistrale a renderla preziosa.
Lo stesso Palahniuk sostiene, rispondendo a chi ipotizza che la pistola di Čechov sia un principio fuori moda: «A renderlo ottimo o pessimo è solo l’abilità con cui si riesce a nascondere la pistola».
In alcuni casi la pistola di Čechov assume una forma diversa e in questo orientamento l’indizio può essere deliberatamente inserito per sviare le attenzioni.
Questa tecnica a cui si fa ricorso nel genere giallo, libro o sceneggiatura che sia, si ritrova quando un autore inserisce un dettaglio per condurre fuori strada il lettore.
Pensate quante volte in un giallo si pensa di aver individuato il colpevole per poi scoprire alla fine della storia che un indizio nel primo capitolo poteva fornirci la soluzione.
Questa è tecnica è denominata Red Herring ovvero l’Aringa rossa.
Attenzione però a chi scrive seguendo le metodologie di scrittura: l’uso avveduto di questi principi rende le narrazioni avvincenti e molto ben costruite, ma basta poco per far divenire disorientante e inefficace questo passaggio depauperando la potenza letteraria del nostro storytelling.
Bibliografia
Brown D., 2003. Il codice da Vinci. Mondadori.
Bunin I., 2015. A proposito di Čechov. Adelphi.
Conti G., L’arte di leggere con i racconti di Anton Čechov. Il Corriere della sera.
Ginzburg N., 1989. Anton Čechov, Vita attraverso le lettere. Einaudi.
Murakami H., 2011. 1Q84. Einaudi.
Murakami H., 2017. Il mestiere dello scrittore. Einaudi.
Palahniuk C., 2020. Tieni presente che. Momenti nella mia vita di scrittore che hanno cambiato tutto. Mondadori.
Marco Mastrorilli

Mi trovo particolarmente d’accordo con la considerazione che chiude l’articolo: le regole esistono per essere violate, direi, estremizzando un po’: insomma, l’importante è conoscerle per utilizzarle o meno a seconda delle circostanze narrative ma senza farne un criterio rigido. Forse la forma narrativa più adatta all’uso della “pistola” è proprio il racconto breve o di media durata, genere in cui Cechov è maestro. Ma dipende. E credo anche che si debba essere in grado di non enfatizzare la “pistola” anzi, di farla apparire quasi di sfuggita, per non rivelare in anticipo il suo senso nell’economia del racconto. C’è un’altra indicazione, che ho trovato in un libro che tratta dell’arte narrativa di Cechov, ripresa da una lettera al fratello (anch’egli scrittore ma di minor fortuna): “Prendi qualcosa dalla vita senza trama e senza finale”. Quando la lessi mi colpì moltissimo e tutt’ora ne sono affascinata. E forse alcuni dei racconti più straordinari di Cechov sono scritti seguendo questo criterio (mi vengono in mente “Tre anni” e “Anna al collo” che sono fra i miei preferiti).
Francesca, è proprio così: personalmente non penso che in narrativa debba necessariamente esserci una chiusa o un finale. E talvolta nemmeno un senso. A volte si asseconda una propria necessità e, tutto sommato, anche il più banale degli accadimenti può prestarsi ad una chiave di lettura e ad una allegoria. Inoltre bisogna (come hai fatto) distinguere tra racconti brevi, medi, romanzi, storie per ragazzi, ecc… Ciascun genere e sottogenere si sposa meglio con determinati registri linguistici. Una cosa è certa: conoscerli e riconoscerli è un accrescimento culturale. Adottarli, una semplice opzione.
Ho riletto volentieri questo articolo interessante di Marco Mastrorilli, ricco di suggerimenti utili. Per me che sono un’autrice per diletto, é necessario rileggere piú volte testi così densi di indicazioni per poter assimilare i concetti legati alle tecniche di scrittura. Nella serie “Le rose e le rouge” che sto ancora scrivendo, ho cercato di tenere presente la pistola di Cechov, nell’inserire nomi e altri elementi che avessero un senso nell’intera storia, pur comparendo inizialmente e poi scomparendo, per cercare di rilanciarli in modo inaspettato. Spero che attraverso questa rilettura riesca a trovare nuova ispirazione e di farmi guidare ancora, nel completamento della serie.
Il modo chiaro e stimolante, con cui l’autore riesce a comunicare – non solo con questi articolo – é anche un esempio stilistico di scrittura, che rappresenta, per me, un punto di riferimento a cui prestare attenzione, sperando di raggiungere un risultato migliore anche nella stesura di altri miei eventuali articoli sulla rivista LibriCK.
Maria Luisa, grazie per la tua testimonianza e per l’impegno che metti nella scrittura. Il percorso dell’autore è fatto di curiosità e apprendimento; è fatto di sperimentazione, altrimenti che razza di alchimisti saremmo? Il percorso dell’autore è fatto di voglia di camminare (come la protagonista de La divina bellezza).
Grazie a tutti voi di Edizioni Open: autori, redazione e Capitano in testa.💝
La letteratura, almeno quella che amo, ha bisogno anche di zone d’ombra: di oggetti che restano sullo sfondo senza assolvere a nessuna funzione apparente, proprio come accade nella vita. A volte sono proprio i dettagli “inutili” a rendere credibile un mondo narrativo e a dare respiro ai personaggi. Credo che la vera abilità non stia nel far sparare ogni pistola, ma nel far scegliere al lettore quali siano davvero cariche.
Perché l’arte non è solo costruzione: è anche mistero, ambiguità, silenzio. Forse le storie più vere sono proprio quelle che non spiegano tutto, e lasciano spazio a ciò che non ha nome.
@pasqualetintore caro Lino, come al solito i modelli narrativi sono delle indicazioni da assorbire con spirito critico, proprio come hai fatto tu. È ultile che facciano parte del bagaglio culturale di un autore, per comprendere anche la storia e l’evoluzione della narratologia. Trovo giusto che ciascun autore peró si affidi alla propria sensibilità e assecondi le proprie suggestioni, altrimenti avremo delle storie tutte molto simili tra loro. E, di riflesso, autori molto simili fra loro. Un caro saluto e grazie per il tuo prezioso commento.