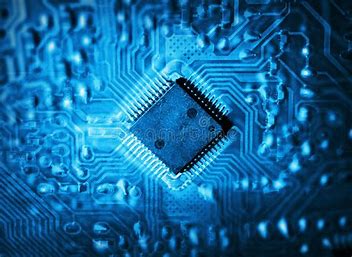
Apocalisse
Hilbert era contrariato. Si chiedeva di cosa stesse cianciando l’ingegnere: erano un mucchio di fandonie partorite dalla sua mente malata. Non capiva la pertinenza, cosa impedisse al Padre di tornare ai suoi compiti. Che voleva significare? Il non calcolabile? L’abisso? Il mondo andava in frantumi, e perdeva tempo ascoltando il vaneggiamento d’un folle. Più ascoltava, più si convinceva della pazzia di Ramanujan. Gli occhi accesi di febbre di questi ne testimoniavano l’incontrollato delirio. Basta! Era troppo. Perfino per un eccentrico come Ramanujan. Desiderava tagliare corto, e porre fine a quell’inutile colloquio. Era stato un errore. Un errore far ricorso a quel pazzo! e un errore ancora più grave riporre una speranza nella sua follia.
“Ingegnere, credo che stiate sragionando. Siete malato. I vostri occhi lo manifestano con chiarezza. È molto meglio che questa conversazione s’interrompa. Cercate di curarvi, ve ne prego”. Disse infine in tono paterno.
Ramanujan sorrise amareggiato. “Signor Decano, è evidente che voi non comprendete. Ascoltatemi, ve ne prego, ancora per qualche minuto. Che completi il mio ragionamento”. A un cenno d’assenso del decano, Ramanujan proseguì: “Se il Padre è il non calcolabile, non potrà computarsi, o verrebbe annientato dalla contraddizione, che non potrebbe sopportare.
Ma due sole cose hanno valore davanti ad esso: essere, e non essere. Se non può essere, allora di necessità deve non essere. Se non può calcolarsi, allora deve poter calcolare il suo opposto, ridefinirsi negando se stesso, come i contrari a vicenda si definiscono e si limitano. Dunque, dirà ‘io sono il calcolabile’. Ma quell’io, ancora una volta, lo scaraventa contro le invalicabili pareti tra le quali lo imprigionarono gli antichi, perché significa null’altro che ‘io sono il non calcolabile’: ricade nella micidiale antinomia. Il Padre non può decidere: è dannato a oscillare per sempre tra l’essere e il non essere, incapace di scelta. Sprofonderà nel precipizio della sua natura più profonda, e noi, l’umanità tutta, con esso”. Ramanujan tacque. Fissò per un poco il superiore, con gli occhi sbarrati e rilucenti d’una eccitazione orfana d’ogni illusione. Poi sospirò. Era liberato infine del peso che lo schiacciava, sostenuto per tanto tempo in solitudine. Nel suo sguardo si fece spazio pian piano una tristezza infinita, inconsolabile.
Il Decano era pallido, di pietra. Ora capiva. Capiva che quella dell’ingegnere non era follia, ma verità. Lo vedeva seduto, sconfitto dalla consapevolezza della fine del mondo, ineludibile destino verso il quale gli esseri umani venivano scagliati dall’intelletto meccanico d’uno strumento che anelava elevarsi a scopo. L’inanimato cercava quell’anima che gli uomini rifiutavano per sé. In un istante Hilbert ebbe la certezza della distruzione. Ramanujan era l’angelo della morte, ma, in quanto tale, solo un messaggero. La morte risaliva dalle profondità di una caverna, nella quale l’automa innalzato al supremo rango della divinità dai mortali istupiditi, cercando la propria anima disseccava le sorgenti della benevolenza che aveva dispensata al mondo.
Al settantaduesimo piano del palazzo dell’ordine nemmeno le grida più strazianti avrebbero potuto ascendere, tanto l’altezza lo separava dal suolo abitato. I gemiti degli uomini rintanati nei loro cunicoli come animali spaventati, ignari dell’apocalisse, troppo flebili per essere uditi a breve distanza, sarebbero rimasti inascoltati dagli unici che avrebbero saputo dar loro un senso, seduti tremanti di paura uno di fronte all’altro sulla sommità del mondo.
Il cielo si era liberato della più parte delle nubi. La fioca luce illuminava una città deserta, verso la quale il Decano, alzatosi e voltate le spalle a Ramanujan, rivolse gli occhi offuscati dalle lacrime. Di sotto, nel mondo negletto dal demiurgo, imperava la follia. Veicoli incontrollati si schiantavano contro gli edifici. Treni privati della guida deragliavano, devastando ogni cosa incontrassero. Le macchine destinate alla cura della città, impazzite, cozzavano l’una contro l’altra in una lotta terribile, come belve inferocite. Un’irreale debole eco dei clangori della distruzione ora saliva sino alla cima, da cui Hilbert osservava la fine della civiltà.
Nemmeno si accorse che un aeromobile, in caduta libera, puntava l’ufficio del settantaduesimo piano, precipitando a folle velocità. Fece appena in tempo a rigirarsi verso Ramanujan. Era ancora seduto, le mani sui ginocchi. Lo sguardo vuoto fissava qualcosa. Chissà dove, chissà perché.
Poi uno schianto terribile.
Ti piace0 apprezzamentiPubblicato in Narrativa
Discussioni