
Guida alla Scrittura: Consigli e Manuali Fondamentali
Articolo a cura di Luca Nesler, pubblicato sul n. 8 di LibriCK – La rivista degli scrittori.
Parlo spesso dell’importanza dello studio per acquisire le abilità necessarie a scrivere in modo efficace e creare opere di qualità, ma la domanda ricorrente è: cosa dovremmo studiare? Ecco alcuni consigli.
Ci sono numerosi testi letterari che è possibile leggere, ma alcuni meritano di essere studiati attentamente. Non consiglio di seguire ciecamente tutto ciò che ho letto sull’argomento, ma ci sono manuali che ritengo fondamentali e altri che suggerirei per chi volesse approfondire la scrittura di storie.
E di quale argomento stiamo parlando? Naturalmente, della scrittura di storie!
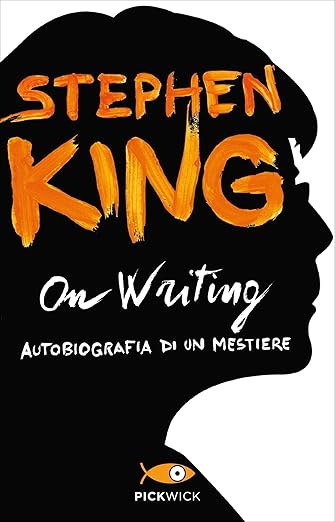
Partiamo dalla tecnica. Molti considerano “On Writing” di Stephen King e “Tieni Presente che” di Chuck Palahniuk come manuali definitivi, fantastici e meravigliosi. Sono letture interessanti e utili, specialmente per chi è alle prime armi, ma vanno prese con cautela poiché sono fortemente biografiche. Tuttavia, offrono un piacevole insight nel mondo della scrittura.
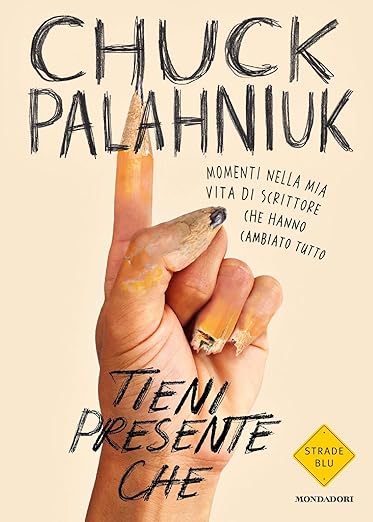
Un testo meno avvincente ma estremamente utile è “Elementi di Stile nella Scrittura” di William Strunk Junior. Questo breve compendio tecnico tratta argomenti come l’ordine delle frasi, la punteggiatura e l’invito a evitare formulazioni negative o indirette. La versione italiana è stata accuratamente aggiornata per adattarsi alle esigenze della nostra lingua.
Parlando di tecnica, consiglio di leggere articoli sull’uso della punteggiatura provenienti da fonti affidabili come Treccani e Crusca. La punteggiatura è spesso trascurata nell’insegnamento elementare e medio, ma è un elemento cruciale da studiare per chiunque desideri scrivere con precisione.
Passiamo ora alla sostanza: come si costruisce una storia?
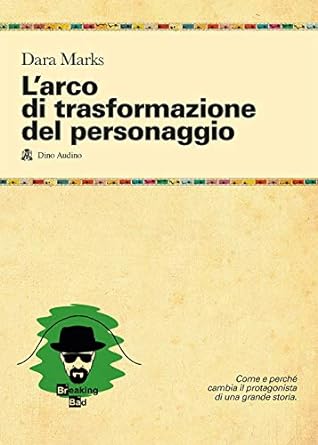
Per comprendere i fondamentali, consiglio “L’Arco di Trasformazione del Personaggio” di Dara Marks. Questo manuale affronta il tema con passione e umanità, esaminando ogni aspetto in modo dettagliato. Marks offre un’applicazione eccellente degli effetti psicologici sulla fruizione della storia e sul motivo per cui funziona.
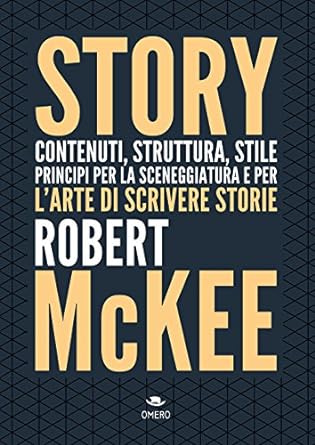
Un altro testo imprescindibile è “Story” di Robert McKee, probabilmente il più famoso dopo Vogler. Ogni frase di questo libro è un aforisma sulla scrittura che vorresti tatuare sulla pelle. Sebbene meno organizzato rispetto a Marks, McKee compensa con una profondità e una cura ancora maggiori. È un testo da leggere, rileggere e, soprattutto, studiare.
McKee ha anche scritto un manuale dedicato esclusivamente ai dialoghi, anch’esso interessante ma non fondamentale, poiché molte nozioni sono già presenti in “Story”.
“Anatomia di una Storia” di John Truby offre un approccio pratico, sebbene meno profondo rispetto a Marks e McKee. Consigliato come lettura complementare, fornisce domande ed equazioni pratiche per la costruzione della storia.
“Save the Cat” di Blake Snyder è molto popolare, sebbene non mi entusiasmi particolarmente. Se hai già studiato altri manuali, può offrire un’interessante prospettiva aggiuntiva. Snyder è noto per la sua praticità, ma la materia è più complessa di quanto possa sembrare.
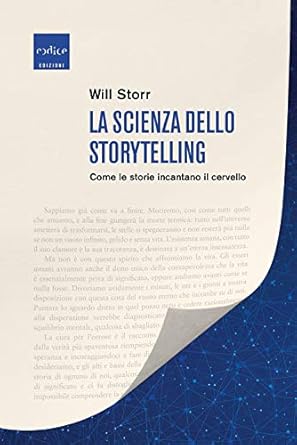
“La Scienza dello Storytelling” di Will Storr esplora il funzionamento del cervello in relazione alla narrativa, offrendo alcune gemme di saggezza.
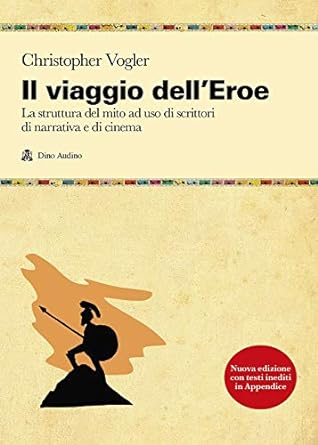
Infine, “Il Viaggio dell’Eroe” di Chris Vogler è un testo interessante, ma non dovrebbe essere seguito come modello assoluto. Evita, invece, “Il Viaggio dell’Eroina” di Maureen Murdock, che è più un saggio psicologico sui conflitti femminili moderni che un manuale di scrittura.
In conclusione, se dovessi leggerne uno solo, opterei per Dara Marks. Se ne dovessi leggere due, aggiungerei “Story” di McKee. Con il tempo, sarai probabilmente tentato di procurarti tutti questi preziosi manuali per affinare la tua arte della scrittura.
Avete messo Mi Piace4 apprezzamentiPubblicato in Blog
Sto finendo il saggio di Dara Marks, che è complesso, ma mi sembra molto utile e approfondito. Il dubbio che mi sta venendo anche in questo caso è che rivolto soprattutto allo sviluppo dei personaggi nelle sceneggiature cinematografiche, dato che tutti gli esempi sono relativi ai film.
Quindi vi chiedo se l’arco di trasformazione dei personaggi sia diverso nei film rispetto ai romanzi.
Caro Federico, ti confermo che buona parte dei manuali di scrittura in circolazione riportano esempi attingendo dalle sceneggiature dei film. Anche molti corsi di scrittura hanno questa impostazione, che francamente non condivido. In linea di principio, però, la struttura di una storia è indipendente dallo strumento utilizzata per raccontarla, quindi i concetti espressi nell’Arco di trasformazione del personaggio possono aiutarti senza dubbio a progettare il tuo romanzo, la tua Serie o addirittura il tuo racconto breve.
Però ci sono delle specificità di un romanzo o un racconto rispetto alla sceneggiatura di un film: ad esempio una maggior possibilità di entrare nella testa dei personaggi con le descrizioni che sono difficili da realizzare nei film. Quindi credo che l’arco del personaggio deve essere molto più schematizzato nelle opere cinematografiche rispetto a quelle letterarie, in cui ci possono essere più variazioni, proprio perché entriamo nella testa dei personaggi. In effetti lo schema in tre atti non lo trovo così spesso nei romanzi, mentre è più frequente nei film.
Cinema e letteratura hanno delle peculiarità. Gli schemi attribuiti ai romanzi sono spesso delle ricostruzioni ex post perché la cultura della pianificazione è relativamente recente; nel cinema, invece, c’è una tradizione più consolidata. C’è da dire che anche nel cinema è possibile esprimere il dialogo interiore dei personaggi ma hai ragione, è più complicato, serve un sapiente uso dello show don’t tell.
Ho preso in biblioteca il saggio di McKee, ma sfogliandolo mi sembra che sia più dedicato alle sceneggiature per il cinema piuttosto che alla scrittura di romanzi o racconti: mi sbaglio?
Ciao Federico, hai avuto un’ottima idea ad andare in biblioteca per prendere in prestito Story. Ti confermo che il volume di McKee, pur affrontando in astratto gli archetipi della costruzione di una storia, è rivolto principalmente agli sceneggiatori.
Li ho letti tutti (McKee in corso) e li ho trovati utili. Studiare è sempre utile.
Daniele questo tuo interesse per la saggistica narratologica denota una grande attenzione verso la formazione. Si vede che hai preso la scrittura sul serio e con la voglia di imparare e migliorarti. Complimenti.
Penso che i manuali siano utili allo scrittore che sia “onesto” con se stesso. Ossia a colui che è consapevole della misura esatta delle sue conoscenze in materia. Non è vero come dicono alcuni che lo scrittore è colui che sa riconoscere i suoi limiti, in quanto i limiti sono anche fatti per essere infranti, ma è quella persona che studia e si informa, è curioso e sa accettare le critiche (sempre costruttive eh) come spinta al miglioramento. Allora, questo scrittore, può leggere tutti i manuali che vuole, che senza dubbio saranno motivo di riflessione. Questo per dire che se lo “scrittore” sa di avere delle carenze a livello grammaticale, per esempio, e non lo ammette nemmeno sotto tortura, è perfettamente inutile che legga manuali di scrittura.
@angycap condivido quello che hai detto. Spesso per pigrizia o per assenza di una vera motivazione verso il miglioramento, tracciare un perimetro e rimanerci dentro è un alibi creato dagli autori per non mettersi in gioco. Altre volte è la paura a paralizzare gli scrittori. La paura di scoprire che il proprio modo di scrivere va rivisto e che bisogna scardinare una serie di certezze e ricominciare. Per crescere servono dei traumi, rimanere immobili è comodo ma non porta da nessuna parte. Amici autori, guardate oltre il vostro stile, guardate oltre il vostro modo di scrivere. Aprite la mente all’idea che migliorare è possibile e che qualcosa va cambiato. Tutto questo è possibile principalmente attraverso lo studio.