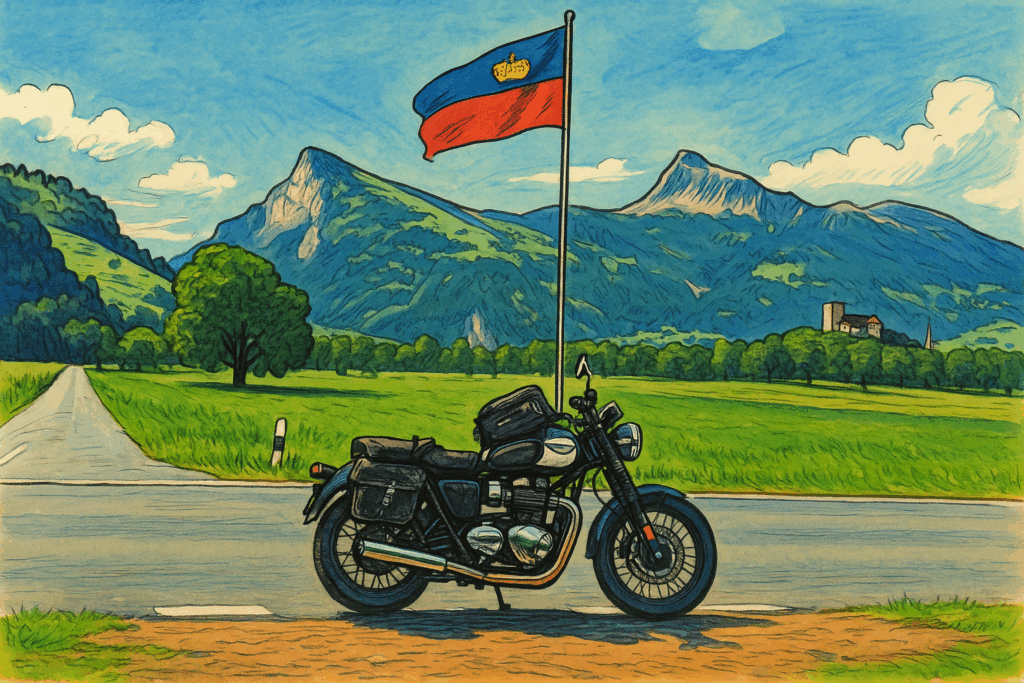
Nessuna ragione per non farlo
Serie: Il solo modo che conosco
- Episodio 1: Cambiamenti
- Episodio 2: Il rivolo sottile
- Episodio 3: Sfide
- Episodio 4: Quei paesi che finiscono per ATE
- Episodio 5: Punti di osservazione
- Episodio 6: Nessuna ragione per non farlo
- Episodio 7: Qualcosa in comune
- Episodio 8: Non oggi
- Episodio 9: Svolte
- Episodio 10: Per la prima volta
- Episodio 1: Coriandoli
- Episodio 2: Privilegi
- Episodio 3: Finestre
- Episodio 4: Il cerchio intorno alla preda
- Episodio 5: Impronte
- Episodio 6: Equilibrio
- Episodio 7: Abitudini
- Episodio 8: La bottiglia vuota
- Episodio 9: Fotografie
- Episodio 10: Non dirlo a nessuno
- Episodio 1: Uno che scrive
- Episodio 2: La finestra sul cortile
- Episodio 3: Inciampi
- Episodio 4: Il corredo delle mie insicurezze
- Episodio 5: Buoni propositi
- Episodio 6: L’evenienza di ricredersi
- Episodio 7: Meriti
- Episodio 8: Rane
- Episodio 9: Una perfetta occasione mancata
- Episodio 10: Il solo modo che conosco
STAGIONE 1
STAGIONE 2
STAGIONE 3
La distanza tra Trezzo e Lecco, da percorrere quasi in linea retta, è poco più di trenta chilometri. Con estrema tranquillità, rispettando i limiti, siamo abbondantemente sotto l’ora di viaggio.
Rifocillato e raffreddato a dovere i componenti della commistione uomo-macchina che ero diventato, l’occasione si presentava ghiotta per arrivare in albergo ad un orario decente, lavarmi, riposarmi e cercare una pizzeria, magari vicino alla riva.
Ma perché rendere tutto così noiosamente lineare e non aggiungerci sopra altri cento chilometri, non andare fino a Como, non costeggiare fino su a Bellagio e da lì non scavallare scendendo lungo quel ramo del lago di Lecco raggiungendo infine la città dall’altro lato? Perché non caricarmi sulle spalle altre due ore e mazzo di viaggio? Appunto! Nemmeno io ho trovato ragione per non farlo! Così all’altezza di Brivio, invece di tirare dritto, ho piegato verso sinistra.
Per un po’ il navigatore ha provato a farmi cambiare idea, indicandomi tutti i modi per tornare indietro e rimanere sul tragitto prestabilito. Poi, attraverso la mentoniera alzata, l’ho visto alzare le braccia in segno di resa e mollarmi lì sul mio percorso ribelle.
«Sai che c’è?» mi ha chiesto visibilmente scocciato, «chiamami quando avrai di nuovo bisogno di me.»
«Dai, non fare l’offeso. Non sei tu, sono io che ho bisogno di qualcosa di nuovo, di uscire dai miei schemi.»
«Fa come ti pare. Tanto alla prima deviazione non segnalata tornerai da me col capo cosparso di cenere.»
L’idea si è rivelata tra le più infelici che potessi avere. Già a partire dai primissimi cartelli che indicavano la dogana, distante ancora trenta chilometri, quello che sino ad allora era stato il traffico regolare di una strada qualunque di un venerdì pomeriggio qualunque si è trasformato in un insieme di tante piccole code, spezzate qua e là da un semaforo o una rotonda.
Sgusciando tra le auto come un’anguilla tra le mani di un bimbo, in qualche modo sono arrivato a Como non senza provare rimorso per la decisione presa senza consultare Greta. Da lì in poi, un fracassamento di maroni senza eguali.
La strada che da Como porta a Bellagio, punto in cui i due bracci del lago si ricongiungono in una più ampia distesa d’acqua, nei primi del novecento quando è stata costruita dev’essere stata una roba mozzafiato. Con il lago che rimane sulla sinistra laggiù in basso, sale e scende restando adesa sulla destra alla roccia della montagna. Le abitazioni rimangono per lo più sulla sinistra, a strapiombo sul blu del bacino.
Capita spesso di passare sotto un arco pietroso o che un’abitazione si allarghi verso la carreggiata creando un restringimento, e immagino che negli anni settanta, quando una Centoventisette incrociava una Cinquecento, fra le due ci fosse tutto lo spazio per fermarsi, spalancare una portiera e passarsi una damigiana di vino.
Oggi la situazione è un pelo diversa. In un mondo in cui abbiamo a disposizione sempre meno spazio e sempre meno risorse, non troviamo di meglio che fabbricare auto sempre più (inutilmente) gigantesche per far immaginare agli altri quanto ce l’abbiamo grosso e possente.
Così quella strada si tramuta da percorso idilliaco a inferno delle nostre vanità, dove guidando verso nord del lago non vedi più nulla; solo lamiere abbacinanti, finestrini oscurati come i veri gangsta-rapper della West Coast, pneumatici più larghi di una corsia e motori surriscaldati, rabboniti da ventole perennemente in funzione.
E tutti, naturalmente, fermi in coda come idioti, senza poterci muovere altrimenti ci righiamo le portiere, ma col sorriso stampato in faccia, perché tanto c’ho l’aria condizionata eammechemminchiamenefotte, guarda qua che cruscotto che tengo.
Sono rimasto fermo tra le auto nonostante le mie due ruote, sentendomi un vero imbecille, parte del problema tanto quanto gli altri, rovinandomi l’immagine di quel posto. La prossima volta ce la organizziamo un po’ meglio.
A passo d’uomo ho continuato a chiedermi quando sarei arrivato sinché, miracolosamente, è comparso il cartello “Bellagio”. Ma a quel punto ne avevo avuto abbastanza di tutto quel casino e senza nemmeno un giretto di rito ho proseguito verso sud, sorpassando appena potevo autobus turistici grossi come corazzate.
C’ho messo un’altra buona mezz’ora per arrivare a Lecco, rallentato da un traffico non più consistente come prima ma sufficiente a non farmi godere appieno di uno spettacolo indubbiamente unico.
Pazienza, come diceva Captain Freedom in “The running man”, senza dolore non c’è vincitore.
Sono arrivato davanti ai cancelli dell’albergo con l’ultimo residuo di carica del telefono, pregando ad ogni svolta che non mi mollasse proprio lì nel mezzo di un posto sconosciuto, ora che mancavano poche centinaia di metri, perseguitato da chiamate spam che si accanivano contro di me e la mia batteria senza accennare ad arrendersi, anzi ben lieti di subissarmi in quel luminoso venerdì sera.
Buoni propositi per il futuro: portarsi dietro un powerbank.
Non vi avevo ancora detto che la prima notte fuori l’avevo dovuta prenotare in un ostello, in una zona della città che non saprei definire con precisione, piena di saliscendi.
Lecco dev’essere una città ambitissima il venerdì sera, ritrovo di vip e zona di smercio di varia natura, tipo i Navigli a Milano ma con molta più acqua intorno, perché l’ostello (per giunta in camerata mista) si era rivelata l’unica soluzione che ero riuscito a trovare in fase di prenotazione che avesse un prezzo sensato. A meno di non andare ad infilarmi in qualche posto in culo ai lupi non ancora raggiunto dall’elettricità.
Una struttura, però, più che dignitosa, che mi sentirei persino di consigliare se muniti di un minimo di spirito d’adattamento.
Una volta effettuato il check-in, la signorina dietro il bancone mi ha lasciato la tessera che fungeva da chiave per la mia stanza (che emetteva ad ogni apertura un suono simile a quello del citofono della Gialappa’s Band) e una consumazione di benvenuto da richiedere al bar.
Poi mi ha accompagnato al garage, dove non senza una punta di apprensione ho lasciato Greta a riposare per la notte. Dopo tutte quelle ore trascorse assieme, chissà come se la sarebbe cavata senza di me?
Serie: Il solo modo che conosco
- Episodio 1: Cambiamenti
- Episodio 2: Il rivolo sottile
- Episodio 3: Sfide
- Episodio 4: Quei paesi che finiscono per ATE
- Episodio 5: Punti di osservazione
- Episodio 6: Nessuna ragione per non farlo
- Episodio 7: Qualcosa in comune
- Episodio 8: Non oggi
- Episodio 9: Svolte
- Episodio 10: Per la prima volta

il mio navigatore e molto monotono-invariabilmente mi fa finire o in un campo di carciofi o di zucchine-poi inversione a u-sei fortunato ad avere un navigatore cosi’ vivace e risentito-cosa vuol dire dormitorio misto -uomini e donne assieme?!?’
Ciao Maria Palma, era uno stanzone con una decina di letti, misto nel senso che ci dormivano sia uomini che donne, ed un bagno in comune nella stanza.
Personalmente, continuo a masticare con fatica la scelta delle note musicali alla fine. Anche perché avendo finito, vorrei andar subito al capitolo successivo ma la curiosità comunque mi fuorvia e allora ascolto. Ma mi trovo solo, in questo caso con un Bob, che forse anche per via della mia età proprio non mi arriva. Non capisco cosa c’entri, non so se dovrei ascoltarla immaginando sto viandante che torna in camera o se inserirla come una ipotetica colonna sonora di tutto quello che nel racconto è avvenuto.
Dopo questo pippone/parentesi, sapevo che questo capitolo avrebbe cambiato marcia e nel constatarlo mi son sentito appagato. Lo scrittore sà cosa vogliamo e ci porta, questa cosa mi infoga molto (si, ho usato deliberatamente una trasposizione sarda sulla lingua italiana, non è dialetto veneto😅🤣). L’infogo nasce proprio dalla foga, cosa che mi hai letteralmente lanciato addosso alla fine di (anche) questo capitolo. Smetterò di esser prolisso e volo al prossimo!
Ciao Loris, sì, capisco, è qualche cosa di sperimentale che può non riscontrare favori. La funzione dovrebbe essere quella della colonna sonora sotto i titoli di coda, se si trattasse di una pellicola, che può essere ascoltata o meno. Saltarla non toglie nulla al film, ascoltarla in alcuni casi può aggiungere, in altri è solo una canzone che magari piaceva al regista. La scelta principalmente si basa su una connessione fra qualcosa che è stato trattato nell’episodio. Può essere nel titolo della canzone, nelle strofe o in tutt’e due. In questo caso ad esempio è solo nel titolo, “Non pensarci due volte”, collegandolo al decidere o meno se fare quella deviazione. Se invece arriverai all’episodio “Per la prima volta”, per farti un altro esempio, la canzone che troverai è lì perchè mi ha sempre rimandato, sin da bambino, all’argomento che ho trattato, soprattutto in un punto specifico dell’episodio. Grazie come sempre della lettura e delle tue impressioni.
“Oggi la situazione è un pelo diversa. In un mondo in cui abbiamo a disposizione sempre meno spazio e sempre meno risorse, non troviamo di meglio che fabbricare auto sempre più (inutilmente) gigantesche per far immaginare agli altri quanto ce l’abbiamo grosso e possente.”
👏 👏 👏
Io sempre e soltanto Panda e non solo per il costo e per i consumi.
Sarà pure che non devo dare esibizioni di potenza.😂
😂😂😂 Con questa mi hai fatto ridere un sacco. Anche io ho una Panda, color bianco ASL. Grazie Maria Luisa, buona giornata.
Grazie Roberto, buona giornata anche a te. La mia ultima Panda é grigio chiaro. Quella precedente era verde. Un vecchio modello. Ribaltando i sedili posteriori ci stavano venti cassette impilate, piene di olive. E un’altra, di seconda o terza mano, con piú ruggine che bianco sulla carrozzeria. L’imprintig l’ho avuto quando frequentavo la scuola guida (quarant’anni fa), con un bravo istruttore.
La mitica Panda consuma poco e poco inquina, soprattutto rispetto ai SUV.
Il tuo racconto contro i macchinoni, per me, é pubblicità progresso.😉
Ma che nervoso la gente con i macchinoni che non solo intasano la carreggiata, quando parcheggiano occupano due posti e metà della strada con il culo del suv. 😾
Dopo code, intasamenti nel traffico e un cellulare in fin di batteria, finalmente il meritato riposo dei guerrieri. Sento io per te la mancanza di Greta. 😹
Fosse per me torneremmo tutti alla mia prima Fiat Uno amaranto, e ce ne sarebbe d’avanzo 😂. Grazie della comprensione Mary!
Che faticaccia le code sul lago il venerdì sera! Mi è piaciuto tantissimo il pensiero finale a Greta, insieme a te è la protagonista di questa avventura, e noi abbiamo il piacere di leggere un racconto non di due, ma di quattro occhi…i tuoi e i suoi.
Oh, grazie per l’apprezzamento Irene, una tappa un po’ loffia ma nel gioco ci sono anche quelle.
Dopo l’ampio respiro dei penultimi due episodi, ammetto che qui, leggendoti, mi sono sentita parecchio soffocare, nonché in apprensione.
Ho deciso allora di lasciar cantare Dylan mentre io lascio il mio commento e, metafora del tuo viaggio a parte (quel titolo!), questa pazzesca melodia mi ha riportato alla solita tranquillità d’animo che possiedo.
Bravo Roberto, un bel viaggio, faticoso, ma bello 🙂
Grazie del commento Cristiana, sono consapevole che questa tappa sia stata un po’ noiosetta ma prometto che le ambientazioni andranno a migliorare😊
Nessuna ragione per non farlo… Ho sentito odore di decisione sbagliata fin da qui😂come negli altri episodi, sei riuscito a rendere benissimo le emozioni e le immagini di questa tappa, stavolta non troppo rilassante.
Bravo Roberto, aspetto con impazienza di ripartire.
Grazie Melania! Adesso che rileggo l’odore lo sento anch’io. Mah, si vede che ero raffreddato in quel momento… 😂
Mi sono lasciata la lettura dell’episodio a oggi perchè sapevo che sarei rimasta a casa, Grazie al tuo resoconto esorcizzo noia e caldo inernale. Sei uno spasso. Bravo!
Cara Tiziana, sapere che ti sei programmata la lettura di un mio scritto per un momento specifico della giornata è il complimento più bello che potessi ricevere. Grazie!
“Per un po’ il navigatore ha provato a farmi cambiare idea, indicandomi tutti i modi per tornare indietro e rimanere sul tragitto prestabilito. Poi, attraverso la mentoniera alzata, l’ho visto alzare le braccia in segno di resa e mollarmi lì sul mio percorso ribelle.” La devo citare così, mi scocciava spezzarla. Fantastica 🤣
Ormai aspettoil nuovo episodio per continuare a seguire le (dis)avventure di Greta e “fantino”…
Hai reso perfettamente l’idea del modo di concepire l’automobile nei nostri anni 20. Per non parlare del turismo.
Eh sì belin, ormai non posso più fermarmi. Grazie Antonio!
“(che emetteva ad ogni apertura un suono simile a quello del citofono della Gialappa’s Band)”
Notevole!
Questo episodio trasuda incazzatura, fatica e sangue. Altro che piacere delle due ruote! Ci racconti una faccia del nostro “Bel Paese” che si è trasformato in una Disneyland per pazzi furiosi, dove ciò che di bello c’è (e c’è davvero) non si riesce più a vedere (o a godere) in questa schizofrenia; tu pensa che lì c’è persino chi ancora ci vive! Mi è piaciuto tantissimo il gps senziente, antesignano degli automi che un giorno decideranno per noi, che placido ti aspetta al varco. E che dire delle dimensioni delle auto? Ingigantite, ma solo all’esterno, figlie della stessa logica che oggi ti fa mettere un casco in testa con 40°… alcuni lo chiamano progresso. Insomma, cose sempre: stimoli tante riflessioni.
Letto davvero con piacere, grazie e a presto.
Ps. da autentico boomer, uso ancora le cartine stradali, la batteria non finisce mai.
Mi piace sempre un sacco come ti immedesimi nella lettura e gli spunti che ne tiri fuori. Grazie della tua presenza come sempre Paolo!
E’ un piacere essere a bordo, Roberto 🙂