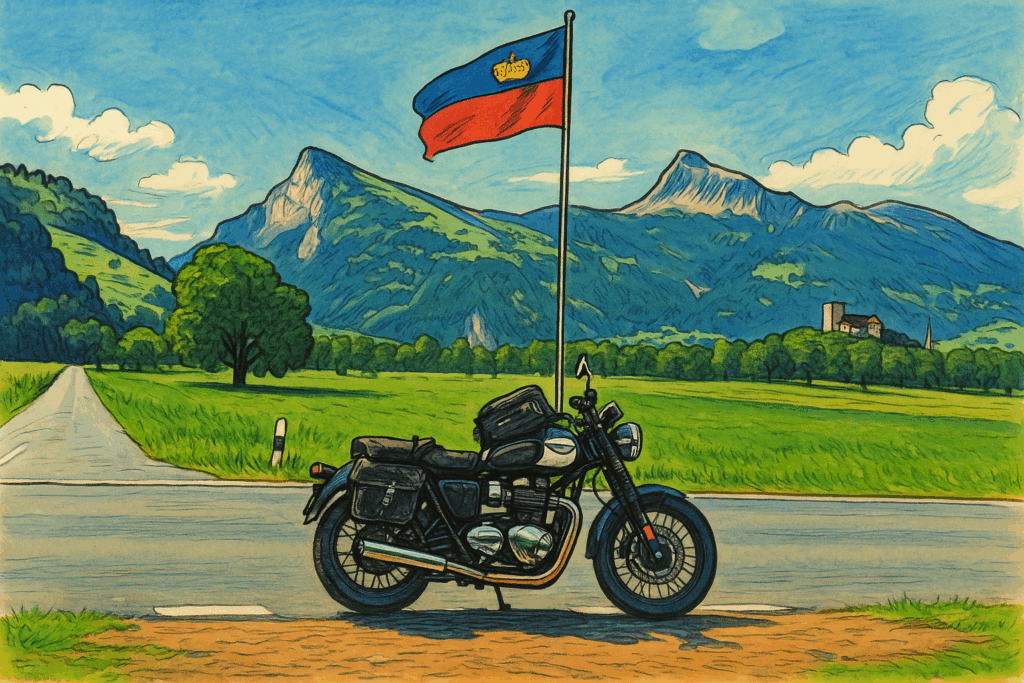
Qualcosa in comune
Serie: Il solo modo che conosco
- Episodio 1: Cambiamenti
- Episodio 2: Il rivolo sottile
- Episodio 3: Sfide
- Episodio 4: Quei paesi che finiscono per ATE
- Episodio 5: Punti di osservazione
- Episodio 6: Nessuna ragione per non farlo
- Episodio 7: Qualcosa in comune
- Episodio 8: Non oggi
- Episodio 9: Svolte
- Episodio 10: Per la prima volta
- Episodio 1: Coriandoli
- Episodio 2: Privilegi
- Episodio 3: Finestre
- Episodio 4: Il cerchio intorno alla preda
- Episodio 5: Impronte
- Episodio 6: Equilibrio
- Episodio 7: Abitudini
- Episodio 8: La bottiglia vuota
- Episodio 9: Fotografie
- Episodio 10: Non dirlo a nessuno
- Episodio 1: Uno che scrive
- Episodio 2: La finestra sul cortile
- Episodio 3: Inciampi
- Episodio 4: Il corredo delle mie insicurezze
- Episodio 5: Buoni propositi
- Episodio 6: L’evenienza di ricredersi
- Episodio 7: Meriti
- Episodio 8: Rane
- Episodio 9: Una perfetta occasione mancata
- Episodio 10: Il solo modo che conosco
STAGIONE 1
STAGIONE 2
STAGIONE 3
Nonostante la camerata fosse vuota quando sono entrato, i costumi da bagno e i vestiti appesi qua e là hanno fatto tramontare definitivamente le speranze ingenuamente riposte in un alloggio tutto per me. Ho approfittato allora di quella momentanea solitudine per occupare il bagno e farmi una doccia, prima che lo facesse qualcun altro al posto mio. L’ostello non è un luogo fisico, è uno stato mentale tanto quanto la provincia, dove ci si muove col coltello perennemente fra i denti.
Dismessi i panni da Jeeg Robot D’Acciaio e indossato qualcosa di meno omino Michelin, ho buttato un occhio al ripiano dove avevo mollato tutta la roba eventualmente sacrificabile al dio dei borseggiatori lacustri e subito mi è saltato all’occhio la cosa più importante fra gli oggetti sparsi: la consumazione di benvenuto.
Afferrata e scese le scale per il piano terra, ho fatto prima una sosta dalla signorina della reception, ponendole una domanda per la quale immaginavo già la risposta.
«Salve, per caso avreste un lucchetto per chiudere il mio armadietto?»
Lo sguardo eloquente della signorina ha sottinteso chiaramente: se eri meno pezzente ti pigliavi una stanza tua e non ti serviva il lucchetto (gli errori grammaticali erano parte integrante dello sguardo). Poi, dopo avermi dato il tempo di elaborare il biasimo che trasudava dai suoi occhi, ha tirato fuori una cartina e col tono più accomodante di quello che usava Gerald Olin al Dolphin Hotel mi ha mostrato una serie di ferramenta in zona, dove comprare un lucchetto che alla fine del soggiorno avrei potuto tenere. Bontà loro.
«Grazie, va bene così, facciamo che mi sento fiducioso» ho risposto salutando con la mano e dirigendomi verso il bar.
«Come preferisce. Non entri nella 1408.»
Mi sono voltato per farmi ripetere l’ultima parte, ma la signorina era già sparita.
Al bancone del bar una giovane ragazza di colore mi ha sorriso appena mi sono avvicinato, ed io ho tirato fuori dalla tasca il gettone di benvenuto.
«Ciao, cosa posso avere con questo?»
La ragazza, paziente, ha iniziato a ripetermi quell’elenco che chissà quante volte avrà dovuto snocciolare nel corso della sua carriera.
«Posso offrirti una birra, un succo di frutta o una Coca. Cosa ti do?»
«Ti sembrano domande da fare?»
La ragazza mi ha sorriso divertita, ha fatto ciò che andava fatto e due minuti dopo ero già seduto ad un tavolino fuori con una birra in mano. Qui, ho assaporato per l’ennesima volta, come fosse stata la prima, il piacere conturbante che regala il primo sorso ghiacciato a stomaco vuoto, quello che per un attimo ti convince che l’universo stia marciando in tuo favore.
Osservando una miriade di ragazzini seduti attorno ai tavoli, ognuno col telefonino davanti agli occhi mentre discutevano di questo e quello, mi sono perso a ragionare su come non sia vera la storia che i giovani non parlano più fra di loro; è solo che lo fanno in modo diverso da come lo facevamo noi. Ho anche considerato che probabilmente, quella notte, avrei dormito poco.
Ho cercato su internet una pizzeria da raggiungere a piedi senza dovere scomodare Greta, che immaginavo già immersa nei suoi sogni di officine scintillanti e olii da motore di prima qualità, optando per una distante circa venti minuti. Così ho prenotato, ho finito la mia birra e me ne sono tornato in una camera ancora piacevolmente vuota, con l’intenzione di sonnecchiare un’oretta.
Non ricordo quanto abbia dormito, sicuramente non l’obiettivo prefissato. So solo che ad un certo punto il citofono della Gialappa’s ha iniziato a suonare come quando da bambino affondavo le mani sui campanelli dei portoni di tutti i palazzi che incontravo per strada. A quel punto una mandria di giovani americani di ogni forma e dimensione è entrata in stanza ed io mi sono arreso all’evidenza.
«Hey man» mi ha salutato uno, probabilmente come fa col portoricano che gli cura il giardino sul retro della villa in New Jersey dove abita con i genitori.
«What’s up dude?» gli ho risposto io, come un vecchio che vuole fare il giovane e del quale è chiaro non ci si debba fidare. Nessuno, ad ogni modo, mi ha degnato di ulteriore considerazione.
Sveglio per sveglio, li ho lasciati a trangugiare confezioni da otto (ciascuno) di merendine industriali e me ne sono uscito con qualche minuto di anticipo rispetto ai piani, scegliendo il giro largo per arrivare in pizzeria.
Faceva ancora caldo nonostante della luce del giorno non fossero rimaste che le briciole, come quel poco di eredità che rimane da assegnare al ramo povero della famiglia quando tutti gli altri già si sono spartiti le fette più grosse. Camminare con la mia polo a maniche corte, leggero come deve sentirsi un palombaro dopo che gli hanno levato lo scafandro, mi ha fatto apprezzare quella porzione di città fatta di palazzi alti e case vecchie ma non ancora antiche che si arroccano verso le montagne, lontano dal lago e dalla zona turistica, quella che cerco sempre di evitare ogni volta che viaggio per non sentirmi piantato come una comparsa in un set cinematografico.
Ho trovato la pizzeria incassata in un’ubicazione oggettivamente infelice, in quelli che sembravano essere i fondi al pian terreno di un condominio popoloso e popolare, con le decalcomanie alle vetrine al posto dell’insegna inesistente; zeppa però di persone che arrivavano senza sosta, cosa che ho preso come un buon segno.
Mi sono lasciato guidare da una cameriera giovane e occhialuta che mi ha fatto accomodare ad un tavolo all’aperto, dove ho consultato il menù accompagnato dalla cantilena di accenti che non conosco.
Ha catturato in particolare la mia attenzione una giovane coppia seduta davanti a me nell’inequivocabile atteggiamento da primo appuntamento, quelle situazioni che ti saltano agli occhi lampanti anche se non sapresti dire perché.
Lei con lo sguardo accondiscendente ma evidentemente annoiato, ascoltava il ragazzo spendersi in una dettagliata esposizione sulla formazione degli Slayer dal 1981 ad oggi.
Ho provato un forte senso di comunanza con quel ragazzino bianchiccio e magrolino, avendo intuito che entrambi, quella notte, saremmo andati a letto da soli.
Serie: Il solo modo che conosco
- Episodio 1: Cambiamenti
- Episodio 2: Il rivolo sottile
- Episodio 3: Sfide
- Episodio 4: Quei paesi che finiscono per ATE
- Episodio 5: Punti di osservazione
- Episodio 6: Nessuna ragione per non farlo
- Episodio 7: Qualcosa in comune
- Episodio 8: Non oggi
- Episodio 9: Svolte
- Episodio 10: Per la prima volta

Un altro bel capitolo pieno di solenni considerazioni esistenziali-col distacco di un nobile decaduto che osserva la plebaglie-fai finta di mischiarti al popolo invece agiti il bastone verso i borghesi come faceva luigi 18 ,
Ciao Maria Palma, è interessante il tuo punto di vista, mi stimola delle riflessioni. Della nobiltà spero sia rimasta solo la decadenza e non la supponenza 😂. A presto, grazie per la lettura come sempre!
Ed io continuo ad esserti grato di continuare la lettura, felice che ti stia divertendo.
Continua a piacermi questa bella avventura che mi cattura, con ogni scena, colorita e ricca di particolari, come fossi al cinema. Mi fa sorridere l’autoironia del protagonista, che trovo in ogni episodio, e il modo in cui ne descrivi, in quest’ultimo, l’aspetto buffo, paragonandolo all’ omino Michelin.
Ops, mi accorgo ora che la risposta era nel punto sbagliato. Avrebbe voluto essere “Ed io continuo ad esserti grato di continuare la lettura, felice che ti stia divertendo”.
Questo capitolo l’ho trovato molto più emozionale. Rispetto agli altri che mi avevano già ben catturato, lui è riuscito persino ad abbracciarmi e darmi qualche gentile pacca sulle spalle. Che bello
Grazie Loris, ne sono molto contento.
“senza dovere scomodare Greta, che immaginavo già immersa nei suoi sogni di officine scintillanti e olii da motore di prima qualità,”
Fantastico😂 ❤️
Ora devi svelarmi il mistero della 1408: cosa intendeva dire la signorina? 😱 Comunque, ho sofferto fisicamente all’idea di dividere la stanza con gente sconosciuta (anzi, diciamo con “gente” e basta 😅)
Niente, deliri miei 😅, è una citazione di un racconto di Stephen King, 1408 appunto, da cui hanno fatto anche un film con John Cusack e Samuel L. Jackson. Grazie per la lettura Arianna.
Ah ecco 😅 non conosco quel racconto e nemmeno il film, ma andrò a cercarlo 🙂
La citazione della 1408 non può sfuggire a un Kinghiano convinto… 🙂
Grande! Quante soddisfazioni che sto ricevendo con questa citazione…
Volevo commentare una frase, ma sono venute fuori solo due faccine sorridenti… Quale? “…comperare un lucchetto che alla fine del soggiorno avrei potuto tenere.”
Fantastico.
😉.
Ho letto l’episodio cercando di tenere a mente le frasi più interessanti, da commentare. Poi ho letto l’ultima e tutte le altre sono passate in secondo piano.
Descrizione perfetta dell’ambiente (fisico e mentale) di chi ha frequentato quella realtà almeno una volta nella vita!
Grazie Antonio. Da ragazzo ho bazzicato gli ostelli molto più di ora, ma in effetti l’atmosfera di base rimane invariata negli anni.
“😃”
😃
Ironia pungente, non smettevo di sorridere. Mitico 💯👏
E con questa sono altri mille punti. Grazie Tiziana!
“«Come preferisce. Non entri nella 1408”
Alla prima citazione ho pensato: mi ricorda qualcosa, dopo controllo! Il numero della stanza mi ha aperto un mondo😂
Grande! Mille punti soddisfazione!
Spassosissimo questo episodio, permeato da un ‘ironia sottile e acuta. Incredibile come tu ti approcci da turista disincantato al mondo difficile degli ostelli, ma allo steso tempo riesci a infondere a ogni scena una magia speciale. La scena finale della coppia è fantastica!
Considerate le cose che scrivi è un complimento che mi tengo stretto
“’ostello non è un luogo fisico, è uno stato mentale tanto quanto la provincia, dove ci si muove col coltello perennemente fra i denti.”
bellissima!
🙏🏻
Questo episodio mi ha ricordato l’acqua di un fiume che scorre verso valle (giusto per rimanere nel tema dei bei paesaggi): un susseguirsi di situazioni randomiche e inaspettate che capitano quando è tutto nuovo ed improvvisato.
È un bene che vengano messe nero su bianco. ✒️
Che bella considerazione, grazie Mary, ogni forma di incoraggiamento ha un valore inestimabile!
Bell’episodio Roberto, davvero. Pieno di quelle boomerate che mi piacciono tanto perché mi ci riconosco:)
Scritto molto bene, come sempre, ma particolarmente frizzante nella narrazione. Dovrebbe descrivere un momento di riposo e invece tutto scorre via veloce. Si sente una specie di adrenalina.
Bellissima l’immagine finale 🙂
Grazie Cristiana, un complimento che mi ridà la carica😘
“Come preferisce. Non entri nella 1408.”
Ma sai che potrebbe essere lo spunto per un torture porn di produzione francese? Ma non mi sembri il tipo 😂 😂 😂
😂In effetti no. È un cameo, e come tale tanto è il piacere di inserirlo quanto quello di immaginare il godimento sui volti dei pochi che lo riconosceranno.
Attento Rob che qui ci sono lettori molto attenti 😉
Sì, mi sono espresso male, volevo riferirmi al fatto che il racconto potesse non essere così conosciuto.
😂😂😂Non posso che iniziare così questo commento. Ma quante chicche ci sono in questo episodio? Dai borseggiatori lacustri allo sguardo sottotitolato della ragazza in albergo, l’arrivo dei tuoi compagni di stanza e il finale. Molto, molto divertente, bravissimo Roberto. Alla prossima tappa!
Grazie Melania, sei una fonte inesauribile di ottimismo e autostima, un po’ come il sorso di birra a stomaco vuoto di cui parlavo.
Dopo il percorso infernale dell’episodio precedente, la desolazione dell’ostello, coi suoi vezzi che dipingi amabilmente, mi dato un senso di gratitudine per non aver mai avuto l’occasione di frequentarne uno. O forse mi hai fatto semplicemente pensare a quanto sia invecchiato. Carino il quadretto finale sulla coppia in pizzeria, dove gli Slayer, insieme all’inserviente incontrata prima al bar, mi han fatto tornare alla mente (roba di parecchi anni or sono…) quando, proprio in quel posto, scoprii che c’era un locale per gli extracomunitari, cose d’altri tempi? Letto come sempre con piacere, grazie e alla prossima.
Grazie Paolo, nei tuoi commenti trovo sempre una visuale a cui non avevo pensato e che mi fa apprezzare la magia dello scrivere e del leggere. Quando dici “proprio in quel posto” vuoi dire che conosci Lecco?
Ciao Roberto, Sì. Vivo a Milano e il Lario è sempre stata una meta delle escursioni su due ruote, specialmente in apertura di stagione… Poi, per vicende di lavoro, un mio parente finì per abitare a Lecco alcuni anni e ebbi occasione di conoscerla meglio, che non di passaggio. A presto