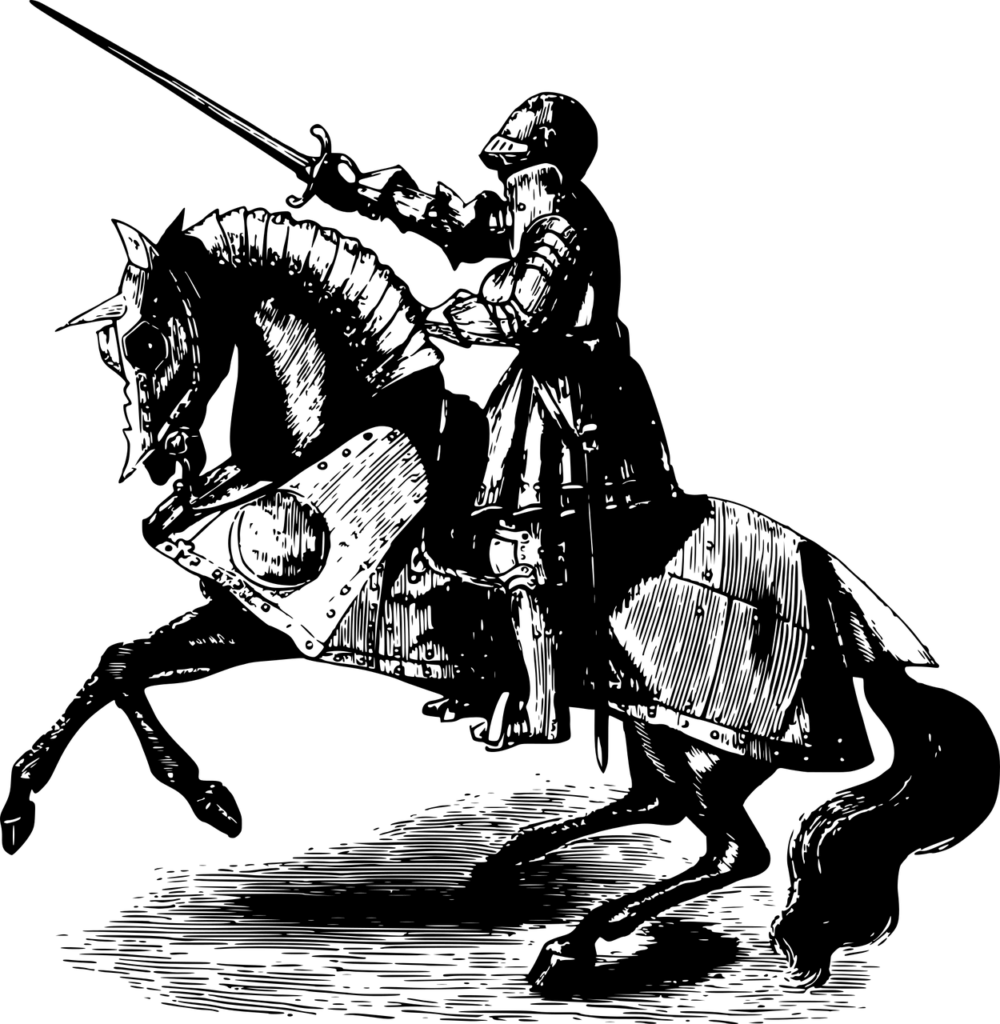
Salvatele la vita
Serie: Il mio avo Marcovaldo
- Episodio 1: Le furie a strisce
- Episodio 2: Attenzione, imboscata!
- Episodio 3: All’armi, Urbe
- Episodio 4: La tremenda sortita
- Episodio 5: Fuga a Castel Sant’Angelo
- Episodio 6: Lo sgradevole assedio
- Episodio 7: Spionaggio nei bassifondi
- Episodio 8: Salvatele la vita
- Episodio 9: Guerra urbana
- Episodio 10: Assalto finale
STAGIONE 1
Roma, 6 maggio 1527
Non poterono fare altro che ritirarsi e cercare un luogo in cui trascorrere la notte: Marcovaldo Albani e il suo portagonfalone, Eriberto, non avevano scelta.
Abbandonarono il cunicolo che conduceva a Castel Sant’Angelo e fra segni della croce e bestemmie rovistarono con lo sguardo tra i resti di una Roma strana, era come se l’Apocalisse si fosse abbattuta sulla sfavillante città eterna. Era quella Roma? La Roma dell’impero prima e del papato dopo, era un corpo marcescente in cui i lanzichenecchi e i loro amici, mercenari spagnoli che avevano rinnegato il cattolicesimo per trenta denari, si divertivano a infierire.
Roma era diventata un unico bassifondo.
Il giorno stava finendo, c’erano pochi pianti e urla, i lanzi si stavano calmando. Solo intorno a Castel Sant’Angelo c’era un assembramento di maiali luterani che arrotavano le lame. Con le loro barbe sudicie sognavano di scannare Clemente VII. Sarebbe accaduto? A Marcovaldo bastava che non scannassero lui.
«Signore, ecco». Eriberto stava indicando una stamberga che quella mattina era stata sorpresa come una vergine al bagno: era stata una dimora di aristocratici, adesso era un trogolo senza veri e propri maiali.
Marcovaldo non poté che accontentarsi. «Cerchiamo di dormire». Fece il suo ingresso. Al di là della puzza di violenza, non c’era nessuno. Già, i porci erano intorno all’ultimo rifugio di Clemente VII.
«E poi cosa facciamo?». Eriberto lo guardò come se fosse un ragazzino: pendeva dalle sue labbra.
«Viviamo alla giornata». Non c’era scelta.
Marcovaldo si gettò in un angolo, si avvolse nel mantello e scacciando l’odore di brutalità si impose di dormire.
Eriberto lo imitò.
Marcovaldo si era addormentato anche dopo le peggiori sconfitte, ma aveva sempre avuto intorno i suoi uomini, che erano sì demoralizzati ma sempre equipaggiati alla guerra e decisi a difenderlo. Eriberto non gli bastava. L’unica difesa era il mantello.
Si sistemò il cappuccio in testa fino a coprirgli gli occhi, si impose di nuovo il sonno.
I muscoli gli si sciolsero, la tensione lo stava abbandonando, all’improvviso Eriberto gli diede una spallata. «Che fai!». Lo guardò obliquo.
«Succede qualcosa». Il portagonfalone si era tirato in piedi, stava correndo alla porta.
Marcovaldo lo seguì.
Là fuori c’era una zuffa in corso. Lanzi infidi e bramosi di sesso forzato stavano strapazzando una giovane, lei ne ferì uno con una spada-gatto.
Una mezza dozzina in tutto, o meglio cinque dato che quello ferito si stava ritirando con le lacrime agli occhi, brandirono le alabarde.
La ragazza aveva davanti a sé un triste destino.
Adesso basta! pensò Marcovaldo. Sfoderò il pugnale, Eriberto lo imitò, si gettarono sui lanzi.
Fendenti, stoccate, le alabarde dei germanici erano insufficienti in un combattimento ravvicinato.
La giovane, invece di scappare piangendo, agitò la spada-gatto e, come se fosse a una caccia al cinghiale, trafisse la gola di uno. La barba si sporcò di sangue e il maiale luterano crollò in ginocchio.
Alla scarsa illuminazione della strada, i capelli biondi della ragazza spiccarono come oro in mezzo al fango.
Marcovaldo diede il colpo di grazia a un lanzo, i superstiti fuggirono, uno inciampò nelle sue stesse viscere. Eriberto festeggiò come se fosse una pasqua, Marcovaldo no:
«Io ti conosco». E dopo una pausa: «Tu sei Nicoletta!».
«In persona». Sorrise rimettendo nel fodero la spada-gatto, una preda di guerra, era evidente.
«Che ci fai qui!».
«Stavo compiendo una ricognizione».
Dopo aver detto quelle parole, schioccò le dita.
Da dietro l’angolo sbucarono degli uomini che indossavano mantelli grezzi, più da contadini del Ducato di Milano.
«Abbiamo sentito dei rumori» disse uno.
«Avevate bisogno di noi?» le si rivolse un secondo.
Nicoletta Rubia li incenerì con lo sguardo. «Se non fosse stato per il mio uomo e il suo portagonfalone, adesso sarei stata smembrata viva».
Chinarono lo sguardo, avviliti.
«Ma non è successo» aggiunse come per consolarli.
Marcovaldo vide che era una decina di uomini, tutti armati per la guerra urbana, qualcosa che, sosteneva sempre, era più sottile delle battaglie campali come Pavia e Melegnano. «Cosa sta succedendo!».
«Sono scesa al seguito degli invasori imperiali per aiutarti con gli uomini che hai preferito lasciare a Varese» gli spiegò Nicoletta.
Marcovaldo serrò le labbra. «Senza che io lo volessi».
Calò un silenzio pesante come la morte.
«Fa niente. Adesso, organizziamoci. Voglio ridurre a brandelli i lanzi» continuò Marcovaldo, dopo aver stretto i denti.
«Magari i romani si uniranno a noi. Dopo quel che hanno subìto». Eriberto indicò un mucchio di cadaveri: le ferite delle spade bagnavano di sangue le pustole della peste.
Marcovaldo sputò. «I romani sono fatalisti: attendono la morte e basta».
Per un attimo lo sconforto sembrò impadronirsi di loro.
«Ma! C’è un ma: gli imperiali sono indeboliti e attendono solo di essere sgozzati». Guardò Nicoletta. «Mia signora».
«Sì?».
«Facci strada fino alla tua base».
La notte calò su Roma, nessuna campana suonò la mezzanotte: suonavano tutte a morto.
Serie: Il mio avo Marcovaldo
- Episodio 1: Le furie a strisce
- Episodio 2: Attenzione, imboscata!
- Episodio 3: All’armi, Urbe
- Episodio 4: La tremenda sortita
- Episodio 5: Fuga a Castel Sant’Angelo
- Episodio 6: Lo sgradevole assedio
- Episodio 7: Spionaggio nei bassifondi
- Episodio 8: Salvatele la vita
- Episodio 9: Guerra urbana
- Episodio 10: Assalto finale

Discussioni