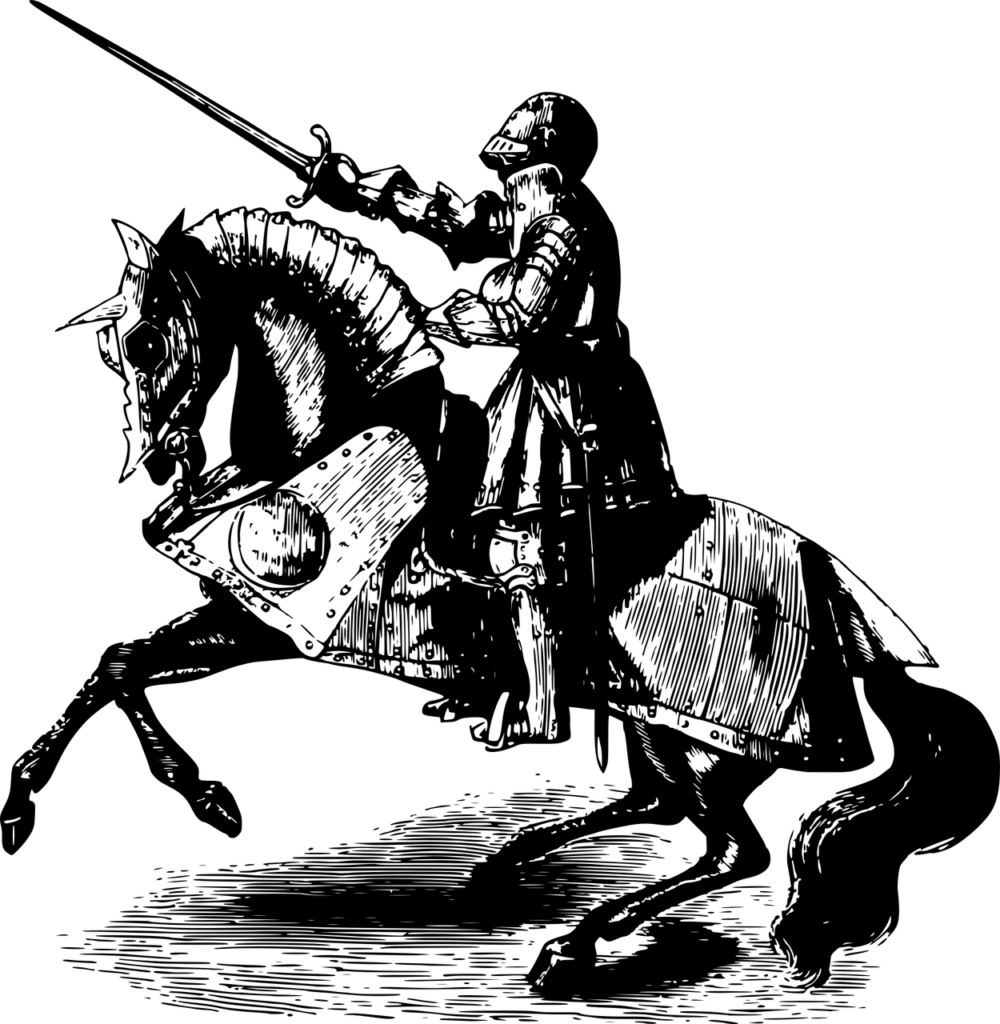
Spionaggio nei bassifondi
Serie: Il mio avo Marcovaldo
- Episodio 1: Le furie a strisce
- Episodio 2: Attenzione, imboscata!
- Episodio 3: All’armi, Urbe
- Episodio 4: La tremenda sortita
- Episodio 5: Fuga a Castel Sant’Angelo
- Episodio 6: Lo sgradevole assedio
- Episodio 7: Spionaggio nei bassifondi
- Episodio 8: Salvatele la vita
- Episodio 9: Guerra urbana
- Episodio 10: Assalto finale
STAGIONE 1
Roma, 6 maggio 1527
Marcovaldo Albani ed Eriberto, il suo portagonfalone, dismisero le armature, indossarono dei mantelli con cappuccio, ma i cappucci non li indossarono: sarebbe stato sospetto.
Grazie a un cunicolo segreto che gocciolava per l’umidità del Tevere, sbucarono fuori da Castel Sant’Angelo.
Roma non era più Roma, ma una Babilonia in rovina: Sodoma e Gomorra.
La puzza di bruciato si mescolava a quella del sangue, degli intestini portati allo scoperto, della decomposizione. Era trascorsa una sola giornata dall’irruzione dei lanzichenecchi e dei loro degni commilitoni, i mercenari spagnoli che erano cattolici come lo era Carlo V, ma questo non gli aveva creato problemi nell’unirsi all’avventura dell’invasione di Roma e il suo saccheggio.
L’avventura…
Più che un’avventura era stata una sventura per gli innocenti della capitale della Cristianità, ma questo pareva far esultare i lanzi, maiali luterani che dimenticavano di chi erano al soldo e consideravano Roma la Babilonia dell’età moderna.
Marcovaldo ed Eriberto si incamminarono per le vie in rovina. Tra edifici ridotti a pire ardenti e altri a ruderi che fungevano da fosse comuni all’aperto, evitarono di attaccare briga con i mercenari imperiali.
Donne stuprate e poi impalate con le picche.
Bambini impiccati e con gli stomaci aperti con le lame delle corte spade-gatto.
Vecchi gettati nel Tevere con dei pesi al collo.
Suore stuprate e sottoposte alla tortura delle braci che le ustionavano in mezzo ai lazzi dei demoni del nord, ma anche preti e monaci umiliati con le tonache rivoltate perché gli si vedessero gli organi di riproduzione ammosciati e, dopo, i lanzi glieli tagliavano per infilarglieli in bocca fino a soffocarli.
Marcovaldo fremeva. Sotto il mantello indossava degli abiti da civile, unico sfizio che gli ricordava di essere un soldato il pugnale.
Un pugnale era troppo poco davanti a spade di ogni dimensione, senza considerare archibugi e falconetti, picche e alabarde e tutto il campionario di armi individuali da adoperare in battaglia.
Marcovaldo doveva sempre ricordarsi che, se avesse agito, avrebbe condannato se stesso ed Eriberto al suicidio.
Forse sarebbe stato meglio, tutto per non assistere allo sfacelo a cui era stata condannata Roma.
Però aveva una missione di spionaggio.
Eriberto taceva. Cereo in volto, gli occhi indugiavano sui cadaveri straziati dall’ennesimo accesso di furia dei lanzi. Anche gli spagnoli non erano da meno, solo un po’ più discreti.
Dopo essere sfilati accanto a una chiesa degradata a stalla, le reliquie bruciate se non fuse perché i lanzi – Maledetti porci! – si arricchissero con i banchieri della Lega anseatica, Marcovaldo disse, più un filo di voce:
«La missione di spionaggio, solo questa».
Eriberto si bloccò, gli diede una gomitata nelle costole. «Guardate».
Di quale nuovo orrore si tratta? si interrogò Marcovaldo. Più che uno spettacolo orrido, davanti a loro c’erano un mazzo di cadaveri. Non esibivano ferite raccapriccianti, erano lanzi, avevano solo dei bubboni che nel pallore mortifero li rendevano più brutti di quel che erano.
Marcovaldo rimase senza fiato.
Si scambiò un’occhiata con Eriberto.
Dopo un lungo istante, forse il più lungo di tutto quel maledetto 6 maggio 1527, Marcovaldo fece una smorfia: «Peste».
«Sì» si limitò a dire Eriberto.
«Dobbiamo avvertire i nostri».
«Sì» di nuovo. Si avviarono.
«Già c’è stato il sacco. Ora… Ora! Tutto peggiorerà».
«Sì» ancora.
Marcovaldo lo guardò con rabbia. «Sai dire solo questo? Roma è condannata. Dopo tutto questo, non esisterà più. A confronto l’incendio di Roma è stato meno».
Eriberto non aggiunse altro.
La missione di spionaggio era stata abortita.
Raggiunsero l’ingresso che conduceva al cunicolo segreto, ci si avventurarono. Dopo un breve percorso, davanti a una porta in ferro, bussarono.
«Chi va là?» udirono.
«Siamo noi».
«Parola d’ordine».
«La necessità fa più ladri».
«Che gentiluomini».
Marcovaldo ed Eriberto si sorrisero. «Siamo in salvo» disse il primo.
Ciononostante, attesero ancora.
Dopo un minuto buono bussarono, i rintocchi sul metallo. «Allora?» borbottò Marcovaldo.
«Andatevene» replicò la voce da dietro l’uscio.
«Come?». Marcovaldo strabuzzò gli occhi.
«Là fuori c’è la peste, magari portate il contagio. Andatevene!» ribadì quel tale.
E fu tutto.
Serie: Il mio avo Marcovaldo
- Episodio 1: Le furie a strisce
- Episodio 2: Attenzione, imboscata!
- Episodio 3: All’armi, Urbe
- Episodio 4: La tremenda sortita
- Episodio 5: Fuga a Castel Sant’Angelo
- Episodio 6: Lo sgradevole assedio
- Episodio 7: Spionaggio nei bassifondi
- Episodio 8: Salvatele la vita
- Episodio 9: Guerra urbana
- Episodio 10: Assalto finale

Molto realistico e ben descritto l’orrore di quel saccheggio, e i bubboni e la peste. Bravo!!!
Grazie di nuovo!
Bellissima descrizione della Roma invasa, si riesce a fare un tuffo nel passato e immaginarsi come doveva essere. Complimenti!
Grazie mille 🙂
davvero bello!
Grazie mille!
“spade-gatto”
Deliziosa nota tecnica, una chicca per chi sa apprezzare la precisione …
Grazie! Mi piacciono questi dettagli